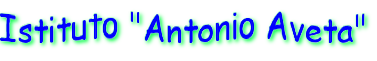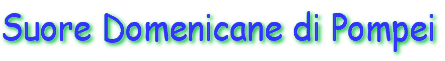Ai Posteri
*Date da non dimenticare *Il nuovo Parroco di Valle di Pompei *L'Archivio e la Biblioteca del Santuario *Le Campane *L'Osservatore Metereologico - Un'iniziativa d'avanguardia *Monumento alla Pace Universale - 1901 *Pompei tra le due guerre *Stele a memoria dell'esperienza mistica di B.L. *Una gustosa pagina di storia scritta da un osservatore dell'ottocento *Cammino Giubilare Longhiano - 01.10.2022/01.10.2023


Per non dimenticare 1875
*Il nuovo Parroco di Valle di Pompei
*L'Archivio e la Biblioteca del Santuario
Custodire la propria storia è una grande opera di bene
L’archivio e la Biblioteca del Santuario conservano migliaia di testi preziosi. Molti studenti li consultano come strumenti indispensabili alle loro ricerche. Ad oggi, sono ottanta le tesi di laurea sulla Nuova Pompei: un motivo di soddisfazione per il Santuario, da sempre coinvolto nella formazione dei giovani anche sotto l’aspetto culturale.
Sono ben ottanta le tesi di Laurea sulla Nuova Pompei – fin ora discusse nelle varie Università d’Italia, tra Napoli, Roma, Bologna, Firenze e Lecce – che si conservano nella Biblioteca e Archivio del Santuario. Quasi tutte intendono portare in luce il carisma educativo – e non solo – del grande uomo della Valle di Pompei: il Beato Bartolo Longo.
È da anni che studenti di tutta Italia, appartenenti a Università e Facoltà diverse, fanno dono della loro tesi.
Ultimo laureato è il dott. Michele Di Virgilio con una tesi sulle Case Operaie.
Discussa presso la Facoltà di Architettura di Aversa, ha riscosso un forte successo: lo studente ha riportato il voto di 110 e Lode e si è meritato anche le congratulazioni da parte di Mons. Carlo Liberati, Arcivescovo Prelato di Pompei, che gli ha inviato questo telegramma: "Accolga vivissime fervide felicitazioni per lodevole conseguimento Laurea in Architettura con la tesi Le Case Operaie di Valle di Pompei e affettuosi auguri di ogni bene desiderato nel Signore".
Queste tesi arricchiscono il grande patrimonio che si custodisce nell’Archivio del santuario, ricco di testimonianze sulla vita e le opere che il Longo ha svolto a Pompei: l’intento del Fondatore della Nuova Pompei era l’educazione dei giovani, soprattutto di quelli per i quali la società del suo tempo non aveva alcuna cura.
Il Santuario di Pompei, anche con questo Archivio e la Biblioteca vuole portare avanti lo spirito del Longo. Perciò, anche dall’insieme di queste tesi, si comprende come l’opera del Beato possa essere letta sotto molteplici aspetti non solo dal punto di vista religioso-devozionale.
L’Archivio storico "Bartolo Longo", che parte dal 1872, anno della venuta del Beato a Pompei, si divide in 25 sezioni. Conserva i documenti personali del Fondatore della Nuova Pompei, la sua corrispondenza privata e pubblica, gli atti del processo di Beatificazione e tutto il materiale relativo alla storia, alla progettazione, alla realizzazione e alla conduzione del Santuario e delle Opere di Carità; le testimonianze di grazie; le Annate della nostra Rivista dal 1884 ad oggi; una raccolta di articoli giornalistici sulla città mariana a partire dal 1883, ed un’importante collezione di santini.
Il processo di riordinamento dell’Archivio è cominciato nella prima parte degli anni ’80 del secolo scorso, quando in contemporanea si volle un Convegno Storico su "Bartolo Longo e il suo tempo" diretto dal compianto prof. Gabriele De Rosa.
La pubblicazione, nel 1983, degli Atti del Convegno e quella della Guida-Inventario dell’Archivio, nel 1986, segnarono l’inizio di una nuova stagione di studi. Si trattava, infatti, di rispondere alle esigenze sempre più avvertite di riportare la figura di Bartolo Longo alla sua reale dimensione storica, al di là
Di ogni intento celebrativo, per avere finalmente una biografia critica del Fondatore della Nuova Pompei.
A tal proposito, un grazie dal profondo del cuore va rivolto a colui che in questi anni – e cioè dal 1981 – ha riordinato l’Archivio: Mons. Antonio Illibato, che fino a qualche mese fa ne è stato direttore. Un commosso e grato ricordo va anche al compianto Cavaliere Aniello Cicalese, suo preziosissimo collaboratore. Mentre, di recente, Mons. Carlo Liberati ha affidato a chi scrive quest’articolo, coadiuvato dal già impegnato Sig. Antonio Maiello, la responsabilità dell’Archivio storico "Bartolo Longo" e della Biblioteca.
Questa Biblioteca, annessa all’Archivio, fu inaugurata il 14 dicembre 2000 da Mons. Francesco Saverio Toppi, allora Arcivescovo di Pompei. Conserva circa trentamila volumi, quasi tutti provenienti dall’ex seminario, da lasciti e donazioni e acquisti presso librerie specializzate. Ci sono inoltre 200 periodici, audiovisivi, CD Rom, edizioni pregiate e spartiti musicali.
Numerosi sono i testi di mariologia e storia della Chiesa, molti i volumi del ‘500 e ‘600, tra le quali l’Enciclica di Ludovico Muratore. La Sala di consultazione è dedicata al marchese Domenico De Luca, grande benefattore del Santuario. Gli studenti possono accedere liberamente alla Biblioteca attenendosi ai seguenti orari: da lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, mentre il martedì e giovedì fino alle 18.
(Autore: Giuseppe Esposito)
*Le Campane del Santuario
Voce forte che invita alla fede
Consacrate il 17 ottobre 1923, furono realizzate nella più antica fabbrica di campane al mondo. La millenaria fonderia Marinelli di Agnone, comune della provincia di Isernia.
Qualcuno ha definito le campane "la voce di Dio", che chiama a raccolta i suoi figli. Il 17 ottobre 1923, nella festa di Santa Margherita Maria Alacoque, Il Cardinale Augusto Silj consacrò le otto campane del Santuario di Pompei, alla presenza del Fondatore Bartolo Longo e della sua consorte, la Contessa Marianna Farnararo De Fusco. Quel fatto storico è ricordato in un prezioso volume, stampato dalle edizioni Enne e redatto da Gioconda Marinelli Sammartino, intitolato "Arte e fuoco, Campane di Agnone". L’autrice fa parte della grande famiglia proprietaria della grande fonderia di campane, con sede ad Agnone, piccolo comune di poco più di cinquemila abitanti nella provincia di Isernia.
La storia dei Marinelli è molto antica e risale addirittura all’anno Mille. Eppure, solo nel 1339, una campana riporta, in bronzo, il nome del suo produttore, Nicodemo Marinelli.
Da allora la famiglia continua a produrre questi autentici oggetti d’arte, capaci di resistere al tempo delle nuove tecnologie e che, nella loro fattura, richiedono conoscenze ampie, non solo relative ai materiali utilizzati e alle forge, ma anche al suono e alla sua musicalità. Per comprendere meglio come nascano le campane, per chi passasse dalle parti della molisana Agnone, è possibile visitare il Museo storico della campana "Giovanni Paolo II", dedicato al Santo Papa polacco che varcò la soglia della più antica fonderia del mondo alle 17,40 del 19 marzo 1995.
L’orario e il giorno sono ricordati in un altro volume di Gioconda Marinelli, "Storia di campane", che racconta nel dettaglio ogni movimento di quell’evento. "Sono felice di essere in mezzo a voi in questo antico centro del Molise, che ha diffuso nel mondo messaggi di cultura e di fede, veicolati dal lavoro dei suoi figli e, in qualche modo, anche dal suono delle sue famose campane", disse il Pontefice in quell’occasione.
Durante la visita assistette anche alla "colata" di una nuova campana, che riporta la profezia di pace di Isaia e che Giovanni Paolo II volle donare all’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Le otto campane del Santuario, dal peso complessivo di duecento quintali, furono tutte dedicate: la prima alla Madonna di Pompei, al Sacro Cuore di Gesù, ai santi apostoli Pietro e Paolo; la seconda a San Giuseppe, Sant’Anna, San Bartolomeo apostolo e Sant’Augusto vescovo; la terza ai quattro evangelisti; la quarta a San Giovanni Battista, a Sant’Andrea apostolo, a San Michele arcangelo e a San Francesco d’Assisi; la quinta a San Benedetto, San Vincenzo Ferreri, Sant’Ignazio di Loyola e Sant’Alfonso Maria de’ Liguori; la sesta a San Gennaro, San Paolino, San Tommaso d’Aquino e Sant’Aristide; la settima a Santa Maria Maddalena, Santa Cecilia, San Pio V e Santa Rita da Cascia; l’ottava ai grandi dottori della Chiesa San Girolamo, Sant’Ambrogio, Sant’Agostino e San Crisostomo.
Nel suo discorso, tenuto nel corso dell’inaugurazione, Edoardo Alberto Fabozzi, Abate della Cesarea di Napoli, disse con la forza della sua oratoria: "Ecco là quelle otto campane, giganti di metallo, ciclopi di bronzo, che dovranno essere le voci celesti, le squille di Dio che qui inviteranno al cuore di Gesù, qui in questa Valle di Maria, le genti d’Italia e del mondo. (…). La campana è forse soltanto un’anima di bronzo? No, è qualche cosa di più: la voce medesima di Dio! La voce di Dio ha un carattere: la brevità nella forza. La parola di Dio non è mai un complesso di ragionamenti (…), non è neppure un interminabile poema, al più è un inno, quasi sempre è una frase sola. Un colpo di luce che è insieme un colpo di forza.
Una frase sola, ma che fa inginocchiare il genio: una frase sola, ma che emoziona e che rinnova il popolo".
(Autore: Domenico Lauria)
Da: Il Rosario e la Nuova Pompei – n° 9 Novembre-Dicembre 2016)
L’Osservatore Meteorologico – Un’iniziativa d’avanguardia
*Una iniziativa d'avanguardia
Cento anni fa, il Beato Bartolo Longo, animato da una visione armonica e di fattiva collaborazione tra scienza e fede, affidava allo scienziato barnabita P. Francesco Denza, il discorso inaugurale della nuova opera che ben si inseriva nel suo progetto per la Nuova Pompei.
Fede e civiltà, carità e scienza sono binomi che si inquadrano nel problema vasto e complesso dei due umanesimi, quello classico-cristiano e quello tecnico-scientifico; problema inesauribile sul piano speculativo, sempre aperto a nuove soluzioni, molto spesso antitetiche fra loro, a seconda se si giunge a conciliare scienza e fede, nello stesso uomo, come espressioni ambedue della sua stessa umanità e della sua unità, o se, viceversa, si arriva a scindere nella persona questi due aspetti fino a ritenere i rispettivi campi inconciliabili.
Per noi il campo è ben delineato. Bartolo Longo è fra coloro che credono nella conciliazione e nella coesistenza fra fede e civiltà, fra carità e scienza e se ne fa carico nel suo percorso esistenziale, nelle sue iniziative: ci riferiamo in particolare all’osservatorio meteorologico da lui voluto e realizzato.
Siamo nel 1890 (cento anni orsono), quando, accanto al Santuario sorge a Pompei la stazione metereologica: è la 253ª in Italia. La prima di queste stazioni era nata 25 anni prima sui ghiacci del Piccolo San Bernardo a 2160 metri.
La storia di queste istituzioni sul territorio nazionale inizia, infatti, nel 1865 quando "si poté costruire una privata società che prese il nome di Corrispondenza Alpino-Appennina e che dopo altri tre lustri, nel 1880, si convertì nell’attuale società Metereologica Italiana, la quale estende ora il suo dominio su tutta l’Italia e su non poche regioni estere dove sono italiani".
Così introduceva il suo discorso, per l’inaugurazione dell’Osservatorio metereorico -geodinamico- vulcanologico pompeiano, il Padre Francesco Denza, Barnabita (nato a Napoli il 7 giugno 1834 e morto a Roma il 14 dicembre 1894), al quale "l’ottimo Iddio ha voluto concedere di poter assistere al 25° anniversario della Società e di prendere parte alla odierna ricorrenza…". Era il 15 maggio del 1890 il quattordicesimo nella vita del Santuario di Pompei e Bartolo Longo nella sua prolusione al momento inaugurale dell’Osservatorio affermava testualmente: "da un lustro in qua in questa Valle memoranda, sotto l’alito fecondatrice della Religione, la civiltà dei tempi nostri si è esplicata in tre grandi manifestazioni: nel Culto, nella Beneficenza, nell’Arte. Restava, ultimo esplicamento della civiltà europea, la scienza, irraggiamento della divinità nello spirito dell’uomo. E la Scienza, questo supremo raggio del sole della civiltà, oggi risplende terso e luminoso a dar la perfezione all’ardua nostra impresa. Di che la umile Valle di Pompei, ignota, inesplorata, negletta per tanti anni dopo il seppellimento dell’antica pagana Città, sarà nominata di lì a poco da tutti i Congressi degli Scienziati, da New York a Londra, da Buenos-Ayres a Berlino".
C’è, ed è evidente, in Bartolo Longo una già chiara visione della progressione storica del mondo e della cultura del suo tempo; ci sono, infatti, i segni premonitori per cui per cui "l’esplicamento" della civiltà europea prenderà il suo abbrivo proprio dallo straordinario, incalzante processo evolutivo delle scienze sperimentali e riuscirà in nome della sua scienza a superare ogni barriera, ad annullare ogni tipo di distanza sociale e geografica.
Così, guardando all’Europa ed agli altri continenti, Bartolo Longo cominciò ad agire in terra pompeiana: aveva iniziato una difficile opera di risanamento etico, aveva ricostruito case e strade e impostato una nuova vita civile, aveva rispettato l’antica civiltà e la sua arte, andava affidando alla carità il suo progetto pedagogico; intendeva includere in questo percorso i prodotti della scienza, i contributi che essa offre all’uomo attraverso l’uomo stesso per rispettare la vita, per migliorarla, per pervenire i danni della natura, per conoscerne i segreti.
L’osservatorio meteorologico di Pompei costituisce uno spunto per "dimostrare come l’uomo devoto a Dio sappia porgere volenteroso amica la mano alla scienza, né rifugga dal progredire sincero dello studio della natura che pure è opera di Dio; e fa quasi intravvedere il sorgere di quel giorno da tutti aspettato, quando i due progressi, materiale e morale, la scienza umana e la divina, la ragione e la fede, stringeranno un’altra volta le rotte sponsalizie" (Denza).
I riferimenti storici e filosofici all’impulso illuministico, al positivismo imperante, alle esasperate diatribe fra i campi della ragione e quelli della fede, il progressivo rientro nei limiti di una visione meno estremista è quel che si sottintende quando si parla di "stringere nuovamente le rotte sponsalizie".
Pompei da semplice centro di Fede intende imporsi come luogo nel quale civiltà e fede si corroborano s vicenda; "Signori, - diceva Bartolo Longo, al numeroso pubblico presente quel quattordici di maggio di cento anni or sono – la terra che voi calpestate è classica… Da quella terra, dalle sue spoglie, sorge "una civiltà novella"".
"A questa civiltà della nuova Pompei, della quale voi, o Signori ammirate qui la molteplice manifestazione, nel Vapore, nell’Elettrico, nella Stampa, nelle Poste, nelle Scuole, negli asili d’infanzia, nell’Orfanotrofio, nelle sale di lavoro, nelle case operaie, nelle Arti venite oggi a dare il compimento con il tributo della Scienza".
Gli antichi non avevano conosciuto né la scienza, né la carità; i Romani "intesi alla conquista e alla definizione del Giure, appresero dai Greci poche e fallaci nozioni intorno a fenomeni più importanti della natura". Né era conosciuta la carità se, come scriveva il poeta Plauto, "chi soccorre il povero fa due mali: perde il suo e prolunga la vita dell’infelice a nuove miserie".
Nell’antica Pompei non vi erano ospedali, né ospizi, né orfanotrofi, gli ammalati, i vecchi, i derelitti erano abbandonati a se stessi, gli schiavi esposti alle fiere.
Oggi, diceva Bartolo Longo già nel 1890, carità e scienza si incontrano, stringono un nuovo sodalizio, scoprono che nell’amore che guida l’uomo allo studio delle leggi e alla registrazione dei fenomeni, nello sforzo della ricerca, nell’ansia delle prove e controprove c’è lo scienziato ed il religioso, c’è l’anima che scopre e l’anima che ammira, c’è la gioia della scoperta e la volontà di non fermarsi dinanzi all’insuccesso; c’è, insomma, l’umano, alterno travaglio di un essere che ricevuta in dono la capacità di "intelligere" si rende conto delle sue prodezze, delle sue conquiste, ma anche dei suoi limiti, dei suoi timori.
(Luigi Leone)
(Da: Il Rosario e la Nuova Pompei – n° 1 Gennaio - Febbraio 1990)
Don Salvatore Sorrentino e Carlotta Amitrano
Curatori della mostra
*Monumento alla Pace Universale - 1901
"Mentre gli statisti discutono, i congressisti si radunano, i governanti si impensieriscono, i pietosi sperano, le popolazioni si immiseriscono e le campagne mancano di agricoltori, in Valle di Pompei abbiamo già eretto un Monumento attestante il desiderio dei popoli, la preghiera dei credenti e l’aspettativa di quel bene sociale tanto desiderato ed invocato: la Pace. E sotto gli occhi di tutti è sorto, a testimonianza del desiderio di tutti, il Monumento di arte e di fede, la Facciata del Santuari, attestante il plebiscito dei poveri e dei ricchi per la Pace Universale".
Lo scritto di Bartolo Longo è del marzo 1901 e conserva, purtroppo ancora intatta, la sua cocente attualità. Abbiamo letto il bel passo per ricordare il movente di un’opera insigne in cui l’arte, la fede, la carità e la fraternità si congiungono in perfetta armonia per significare nella pietra il sospiro e la preghiera di ogni uomo per la pace universale.
Il Santuario era nato infatti come opera di fede e di carità: un prestigioso disegno con la mira principale di affratellare gli uomini di ogni razza, di ogni colore, di ogni lingua. Cominciato con l’obolo umile di pochi fedeli, si portava a compimento con l’offerta, spesso generosa, del mondo intero. La Cina, l’India, le Americhe, l’Europa, in special modo, avevano concorso alla edificazione di un’opera di così vaste proporzioni: uomini di origini e di culture le più disparate, avevano univocamente aderito ad un programma che inneggiava alla fratellanza, alla carità, alla pace.
Già nel Febbraio del 1886, dalle pagine del periodico Il Rosario e la Nuova Pompei, Bartolo Longo aveva levato la sua voce suadente invocando il concorso per un’opera religiosa e sociale e ne aveva fatta propaganda in tutto il mondo, con l’intento di ottenere il consenso e l’offerta universale, da spendersi per il Monumento della Pace Universale.
La prima pietra fu collocata il 15 maggio 1893, lunedì, alle ore 10,30. Il rito fu presieduto dal Cardinale Raffaele Monaco La Valletta, decano del Sacro Collegio assistito dai Vescovi delle diocesi limitrofe e dal numeroso Clero Pompeiano.
Alla presenza di una folla immensa di fedeli in preghiera, la prima pietra della nuova e grandiosa facciata del Santuario, fu benedetta e rinchiusa in una teca di marmo pregiato. Nella stessa teca si collocarono tre monete e tre medaglie della Vergine di Pompei, una pergamena che recava scritti i nomi di Bartolo Longo e della Contessa sua Consorte, del Cardinale Monaco la Valletta e di tutti i sacerdoti addetti al Santuario.
La statua, alta metri 3.25, rappresenta la Vergine del Rosario in piedi; sulla sua base di marmo aggettante, secondo l’antico desiderio del Vescovo di Nola, Mons. Giuseppe Formisano, si sarebbe dovuto scrivere a grandi lettere di bronzo: "Non nobis, Domine, non nobis; sed nomini tuo da gloriam" (Non a noi, non a noi, ma al tuo nome dà la gloria).
Bartolo Longo per ispirata disobbedienza, fece incastonate, invece, su quel marmo, la parola PAX. E lo fece con profonda convinzione. Più tardi, infatti, scriverà risoluto: "Il mio testamento è questo: vi lascio la pace". Un giovane napoletano, lo scultore Gaetano Chiaramonte, appena uscito dalla scuola della R. Accademia delle Belle Arti di Napoli "l’aveva levata dal marmo": un colossale monolito di Carrara, bianchissimo. Don Bartolo non tralasciò l’occasione per creare una cerimonia significante: la benedizione della statua della Vergine prima che fosse issata sul fastigio della facciata. "Con questa benedizione che cosa intendiamo fare? Noi col benedire questo marmo, che è l’effige della Vergine, della Regina di questa Valle, benediciamo anche gli operai che per 25 anni hanno spese le loro fatiche; i benefattori di tutto il mondo, tutti quelli che ci hanno dato modo per compiere l’opera che Dio affidava al vostro e nostro cuore. È compiuto il Monumento glorioso che porterà ai secoli venturi la memoria e l’attestato indelebile e imperituro della nostra fede e della nostra carità"
*Pompei tra le due guerre
L’universalità della pietà mariana di Bartolo Longo
Il modello di preghiera pompeiano pienamente rispondente alle esigenze religiose della società negli anni a cavallo tra i due conflitti mondiali.
Ricorre quest’anno (1996) il 70° anniversario della morte del nostro Fondatore il Beato Bartolo Longo. È una ricorrenza, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, che impegna la nostra – e soprattutto la "sua" – rivista in maniera del tutto particolare. Per questo, durante tutto l’anno dedicheremo alla figura di Bartolo Longo una serie di servizi speciali e approfondimenti che avranno l’obiettivo di far conoscere sempre più a fondo anche il clima, le condizioni storiche e sociali nelle quali si è sviluppata la sua feconda azione sul versante della carità e del riscatto della dignità umana. In questo senso proponiamo un intervento del professor Roberto Violi, docente di Storia moderna presso l’Università "La Sapienza" di Roma, studioso e saggista sulla realtà della chiesa del mezzogiorno.
L’esperienza religiosa di Pompei, nei decenni che seguirono immediatamente la morte di Bartolo Longo, si sviluppò lungo le linee che egli stesso aveva indicato e assunse una più precisa fisionomia in rapporto alle trasformazioni delle società italiana degli anni Trenta e Quaranta e ai grandi eventi collettivi di quel periodo. Una particolare sintonia si era stabilita intanto si era stabilita intanto nell’effettivo svolgimento della storia di Pompei con le permanenze socio-culturali contadine tipiche della industrializzazione dell’area napoletana. Ma negli anni tra le due guerre, soprattutto, si era andato confermando il processo di rottura dei mondi comunitari tradizionali del Mezzogiorno. Complessivamente sembrava delinearsi una tendenza della religiosità a compenetrarsi meno nelle durezze, nella mentalità e nei conflitti di una società contadina, e ad entrare piuttosto in una qual certa sintonia con la normalità di una cultura urbana media, secondo gli esiti o le inclinazioni di tutta la cultura meridionale, attratta o coinvolta nei circuiti della trasformazione e della interdipendenza del mondo contemporaneo.
Un modello di pietà mariana come quello proposto da Bartolo Longo, non legato rigidamente a precise identità comunitarie, né alle scadenze della vita di campagna né a particolari cicli rituali, rispondeva pienamente alle esigenze religiose di quell’epoca.
Il Santuario di Pompei si caratterizzava sempre come più come il santuario della lontananza degli emigrati e degli italiani residenti all’estero per le guerre e per le vicende coloniali.
La forma della preghiera pompeiana si collegava, dunque, ad una nuova condizione universale dell’esperienza umana.
I "Quindici Sabati", la Novena, la Supplica, riprendevano il carattere di una unanimità cattolica, mentre il Rosario costituiva una delle preghiere popolari più capaci di realizzare una concordanza con la vita di tutti i giorni e con ogni circostanza della vita moderna. La preghiera silenziosa di Pompei si distaccava dalla religiosità clamorosa della festa "napoletana" di altri santuari tradizionali.
Nel rapporto dei devoti con la Vergine di Pompei aveva spesso rilevanza il ringraziamento per tutto il corso di una esistenza assistita dal patrocinio di Maria.
Si attuava in qualche misura il ricorso straordinario alla Madonna risolutrice di casi impossibili e nel prevalente orizzonte familiare e quotidiano della preghiera non erano assenti le richieste di grazie spirituali, sebbene permanessero numerosi i richiami alle malattie e a tutte le condizioni materiali dell’esistenza.
La possibilità di contatto con la persona del fondatore, che riviveva nelle opere e nella memoria dei pellegrini in visita a Pompei, diffondeva un modello di santità che si proponeva non per la straordinarietà del prodigio, ma per la forza del contagio di una vita esemplare condotta nella carità e nella preghiera.
Importanza maggiore assumeva, in quel contesto, la forma scritta del voto, con la pubblicazione della "grazia ricevuta" sul periodico fondato dallo stesso Bartolo Longo. Non era quella una sorta di propaganda sacra, ma una dilatazione dello spazio di pertinenza del santuario di Pompei fino allo stesso mezzo della comunicazione di massa, entro cui si amplificava l’eco della benevolenza divina invocata dalla accorata preghiera degli uomini a Maria.
Scorrendo le pagine del periodico per gli anni tra le due guerre si coglie con chiarezza il complessivo orizzonte esistenziale dei devoti costituito da lavoro, salute e famiglia. La grande crisi economica del ’29, esplosa negli Stati Uniti, era da tutti percepita nei suoi effetti immediati della disoccupazione e del tracollo delle piccole e grandi attività economiche di molti che scrivevano dall’America e dall’Italia, per invocare la grazia di una ripresa degli affari o di un posto di lavoro che ridesse una qualche serenità alla propria famiglia.
Molteplici erano poi, tra i fattori della mentalità entro cui si definivano le concrete forme storiche della preghiera, gli elementi della insicurezza che l’esposizione ai rischi della modernità comportava. Molti scrivevano per invocare o per ringraziare la Vergine in occasione di un nuovo impiego in sedi lontane dai propri luoghi di residenza, di esami, di pubblici concorsi, di arruolamenti militari e di trasferimenti di ufficio.
La grande maggioranza dei devoti chiedeva grazie relative alla buona salute propria o dei propri familiari.
L’intervento della Santa Vergine era richiesto non in sostituzione, ma a sostegno di quello dei medici e chirurghi, perché fosse rassicurato chi si sottoponeva a nuove forme di terapie o magari all’anestesia per una operazione. In occasione delle guerre d’Africa e di Spagna fu avvertita, nel movimento ininterrotto della pietà mariana di Pompei, l’esigenza di alimentare l’ardimento eroico dei combattenti per la causa di una nazione italiana in armi per le sue conquiste e per le sue manifestazioni di potenza.
Il Rosario fu comunque un sostegno importante della condizione personale dei soldati.
Durante la seconda guerra mondiale prevalse però il registro del dolore e della consolazione. Nella ricerca di un rifugio e nella comune invocazione di tanti figli ad una stessa madre si definì un preciso sentimento di solidarietà che accomunò gruppi familiari e locali e aprì ad una dimensione concreta e universale della carità. La guerra, poi, rimase impressa nell’immaginario di tutto un popolo in preghiera negli anni che seguirono il secondo conflitto mondiale. L’invocazione prevalente fu allora quella di una convivenza nella pace e nel lavoro che interpretò bene, al di là delle paure di quegli anni, le aspirazioni comuni di tanti italiani.
(Autore: Roberto Violi)
*Stele a memoria dell'esperienza mistica vissuta da Bartolo Longo
*Una gustosa pagina di storia scritta da un attento e scrupoloso osservatore dell’ottocento in visita a Pompei (Parte Prima)
"Poniamo in posto di onore questo bellissimo articolo che ci viene regalato dal Chiarissimo Prof. Cav. Cosimo De Giorgi (*), onore della provincia di Lecce, conosciuto in tutta Italia come profondo geologo ed ameno scrittore e poeta".
È il giudizio che esprime B. Longo pubblicando, nel 1887, l’articolo sul 1° fascicolo de Il Rosario e la Nuova Pompei.
A cento anni dalla stesura di essa – Natale 1886 – si ristampa la gustosa pagina di storia scritta con acume e brio da un attento e scrupoloso viaggiatore-osservatore ottocentesco.
Una escursione nell’autunno del 1886. Impressioni e ricordi
Non par vero, ed è un fatto. In un secolo come questo tanto miscredente e tanto materialista (1), Valle di Pompei (2) sembra quasi un anacronismo, e ci riporta con il pensiero almeno ad un millennio addietro. Allora una chiesa, una cappella, una cripta sacra, un convento, un palazzo baronale divenivano le cellule primigenie intorno alle quali altre se ne aggruppavano per costituire una bicocca, che poi diveniva una terra o un Castello e quindi una Città.
In questa mia Provincia (3) per es. moltissimi paesi ebbero questa origine nel medioevo, tanto sotto la dominazione bizantina, prima dell’XI secolo, come sotto i Normanni e gli Angioini. Potrei citare tra i paesi greci: S. Eufemia, S. Dana, S. Giorgio sotto Taranto, S. Demetrio, S. Potito, S. Teodoro, S. Sotero, ecc.; S. Pietro in Lama, S. Pietro Vernotico, e S. Pietro in Galatina; su quelli sorti al tempo dei Normanni, Cerrate ed Aurio; e nel periodo angioino le due città di Francavilla Fontana e di Martina Franca. Una chiesa diveniva il centro di attrazione per le nuove abitazioni; ed i re, i principi, i vescovi e i feudatari locali – sempre devoti anche tra le loro iniquità (4) – favorivano con privilegi, con donazioni, con franchigie questi incentramenti.
Ma in questo secolo scettico (5) veder sorgere, nella regione più ridente d’Italia, ai piedi di un monte sempre fumante, spesso innivomo (6), circondato da una vegetazione meravigliosa, in un paese intorno ad una chiesa dedicata alla Vergine del Rosario, sembra per lo meno strano, se non vuol dirsi miracoloso! E dire che la chiesa stessa non ha neppure il carattere della vetustà, ma appena un decennio di vita ed anzi è tuttavia in costruzione (7); e di già intorno ad essa si va formando un gruppo di case, nel quale però si trovano elementi di civiltà moderna che invano si cercherebbero in città popolose e ricche di gloriose e antiche memorie. Valle di Pompei è nota oramai nel vecchio e nel nuovo mondo; e quando saranno rivedute le carte d’Italia, pubblicate qualche anno fa, dall’Istituto topografico militare, sarà certamente segnata questa nuova borgata, a mezza via tra Scafati e Pompei, nel punto oggi designato su quelle carte con i nomi di De Fusco e De Vivo (8).
Io vi giunsi il 3 di settembre di questo anno. Ero venuto da Lecce per la via di Taranto. Dopo aver traversato l’uggiosa Valle del Basento, mi ero fermato qualche ora in Potenza. Rividi le colline e le montagne che circondano questa città e che io ben conoscevo, perché avevano messo a dura prova le mie gambe in una ricognizione geologica della Basilica eseguita nel 1877 per incarico del Comitato geologico.
Di là traversata la Valle del Platano, che continua con quella del Sele, dopo aver dato un saluto alla gloriosa città dei Principi longobardi e di Roberto Guiscardo, ed ai panorami bellissimi della costiera di Amalfi e delle montagne di Cava, di Nocera e di Pellezzano, entrai nella ridente pianura traversata dal fiume Sarno, a ponente della quale si erge nereggiante il cono del Vesuvio, come un faro sempre acceso da Mamma Natura, come un simbolo del nostro carattere meridionale!
Quella pianura gremita di paesi, solcata da vie e da canali, ricca di una flora lussureggiante, piena di vita industriale, lambita ad occidente dal golfo di Napoli, e senza dubbio la più bella d’Italia: "è un pezzo di cielo lanciato in Terra!"
E proprio nel mezzo di questo cielo si eleva maestoso ed elegante il trono alla gran Madre di Dio, a poca distanza dalla Strada Ferrata che da Nocera corre difilato a Torre Annunziata.
Note
Negli ultimi decenni si rivolse più intensamente agli studi di storia e di archeologia, iniziati molti anni prima.
Aveva cominciato da medico, ma poi non c’è fenomeno, si può dire, della vita salentina che non abbia studiato con maggiore impegno. Né era pago di parlare, scrivere, consigliare, organizzare. Non era uno studioso da tavolino, un paziente collezionatore di notizie, ma, innamorato del suo paese, viaggiò instancabilmente, per la ragione che, per tutta la sua lunga vita, si sentì socialmente impegnato".
(da: Tommaso Fiore, Formiconi di Puglia. Lacaita, Manduria. 1963, pasdsim).
(1) "O Vergine Immacolata e Regina del Santo Rosario, Tu, in questi tempi di morte fede e di empietà trionfante, hai voluto piantare il tuo seggio di regina e di Madre sull’antica terra di Pompei".
È l’invocazione con cui B. Longo inizia la sua Novena alla Vergine, siamo sul finire dell’anno 1878. Il secolo miscredente e materialista, i tempi di morta fede e di empietà trionfante sono chiare allusioni al Positivismo: l’indirizzo filosofico condiviso e seguito, sul finire del XIX secolo, da tutti i paesi del mondo occidentale.
Si consideri che il Positivismo, sistema filosofico eminentemente realista, privilegiando esclusivamente il metodo della scienza e ritenendo essere l’unico valido in ogni campo dell’indagine e dell’attività umana, portava a negare qualsiasi espressione di fede. Ne scaturiva in conseguenza la desolante preclusione ad ogni rapporto dell’uomo con la trascendenza.
(2) Antica denominazione del territorio. Si chiamò Pompei dal 29 marzo 1928, con l’istituzione del Comune Autonomo.
(3) Il de Giorgi era nato a Lizzanello in provincia di Lecce.
(4) Forse costretti ad essere "divoti" in segno di pentimento o per espiazione delle "loro iniquità"?!
(5) Ancora ribadisce, accorato, il concetto di scetticismo dilagante nel campo della religione e della fede. La profondissima devozione per la Madonna ed il fervore con cui si vanno realizzando le opere pompeiane, stupiscono il De Giorgi al punto di fargli attribuire a miracolo quanto sta accadendo in questa terra.
(6) Si allude al superbo pennacchio di fumo che scaturiva dal Vesuvio. Il suggestivo spettacolo non è più visibile dal 1944, epoca dell’ultima eruzione.
Va ricordato inoltre che a fine agosto 1886 (il De Giorgi arriva a Valle di Pompei il 3 settembre), il dinamismo del vulcano si accentuò al punto che in alcune occasioni si ebbero getti di proiettili e di cenere accompagnati da boati.
(7) È il primo decennio della fondazione della Nuova Pompei ed anche il più fecondo per le opere religiose, caritative e civili realizzate. Si consideri che il Quadro miracoloso della Vergine arrivò a Pompei la sera del 13 novembre 1875 e già l’8 maggio 1876 fu posta la prima pietra per la erezione del grandioso Tempio. Appena cinque anni dopo il rustico della costruzione era già portato a compimento e nel 1883, l’8 maggio, si recita per la prima volta la Supplica: il 14 ottobre dello stesso anno si celebra nella chiesa la prima grandiosa festa del Rosario. Durante l’anno 1884 si apre l’ufficio postale e si ottiene la fermata del treno a Valle di Pompei; si pubblica il primo fascicolo del periodico Il Rosario e la Nuova Pompei; sono in fase di completamento gli Asili Infantili, la Tipografia, le case per gli operai del Santuario, la cupola del tempio, l’Altare maggiore e il Trono della Vergine.
(8) In quell’epoca il territorio – che costituirà l’attuale Comune di Pompei – era diviso in quattro ineguali porzioni di terra assegnate a quattro Comuni diversi e a due Province. La designazione sulle carte topografiche con i nomi di De Fusco e De Vivo era opportunamente suggerita in quanto le due famiglie possedevano le più notevoli estensioni terriere; basti considerare che la proprietà del Conte De Fusco, defunto consorte della Contessa Marianna Farnararo, era formata da circa 54 moggi di terra ed alcune case.
(Nicola Avellino – Il Rosario e la Nuova Pompei – n° 4 Gen.-Feb. 1987)
Alla Stazione mi aspettava un carissimo amico mio, Ludovico Pepe (4) da Ostuni, che dirige e sopraintende ai lavori della Tipografia di Valle di Pompei (5). Questo giovane coltissimo, negli ozii non troppo frequenti della sua professione, si occupa di studi storici ed archeologici, sua vecchia passione, e cerca negli archivi e fruga sotterra i documenti illustrativi di questo paese che va sorgendo presso l’antica città di Pompei, oggi in gran parte dissepolta.
Il Pepe per esempio ha trovato che poco lungi dalla nuova Valle di Pompei esisteva nel medio evo un altro paese dello stesso nome, che fu distrutto nella seconda metà del XVII secolo. Il nuovo è quindi una risurrezione dell’antico paese, e non già della città di Pompei, la quale, sepolta dall’eruzione vesuviana del 79 dell’era volgare, ritornò alla luce soltanto nel secolo scorso, ed oggi resta come uno splendido monumento del tempo romano.
Egli ha raccolto inoltre molti materiali per la Storia dell’antica Valle di Pompei, notata dagli storici per la prima volta al tempo dei Normanni, nel 1087. Poi divenne comune e quindi feudo della famiglia Piccolomini. La sua vera posizione è là dove oggi sorge il R. Polverificio di Scafati, presso il fiume Sarno e ad un chilometro di distanza dalla chiesa del Rosario.
Quando giunsi in Valle il giorno volgeva già al suo termine e una nebbietta diafana ricopriva con un velo trasparente tutta la pianura. In Valle di Pompei ancora non vi sono alberghi: ma ve ne ha parecchi in quei dintorni.
Il mio Mentore mi condusse all’hotel, che resta più vicino al Santuario, e dove il sole non nasce e non tramonta mai, perché è dipinto goffamente in rosso sul muro che guarda la via che mena da Torre Annunziata a Scafati. È denominato Albergo del Sole e pare una rustica villetta, senza le pretensioni di Diomede, e con tutti gli agi di una libera vita patriarcale. Vi è una casetta in fondo ad un viale ornato di fiori, un’altra sulla via, ed una terza – la sala da pranzo – nella quale valenti pittori han riprodotto con molta arte alcune scene di vita pompeiana dipinte sulle pareti di Pompei.
Il padrone dell’Albergo è Monsu Nicola (6), che all’aspetto pare un vecchio pompeiano sbucato dagli scavi della "via della Fortuna". È un uomo cortese, pieno di buona volontà, che biascica diverse lingue, e di un’amena conversazione: se Monsu Nicola tira il collo ai capponi, è soltanto su questi volatili, che egli esercita la sua crudeltà!
Nella sera volli percorrere la via che mena verso Torre Annunziata: Fiancheggiata di platani e di aceri giganteschi, larghissima, corre sempre in pianura, rasenta Pompei e quindi si unisce con l’altra che viene da Castellammare.
Di là godei lo spettacolo del Vesuvio in eruzione.
Sul cono centrale sembrava accesa come una grande pira rossastra e alla base di esso, nell’Atrio del Cavallo (7), altre cinque fiaccole rosse uscivano dai crateri di lava incandescente.
Di tratto in tratto dal vertice del cratere centrale, veniva su un globo di fuoco che giunto ad una certa altezza scoppiava, come un razzo di fuochi artificiali producendo una cupa detonazione.
Allora mi ricordai dell’ultima ascensione che avevo fatto sul Vesuvio con il P. Denza, con il Sindaco Giusso e con tutti i miei colleghi del Congresso meteorologico di Napoli nel settembre del 1882.
Si era scelta una orribile giornataccia; ma pure l’escursione riuscì divertentissima. Il cono centrale era tutto involto nelle nubi e sporgeva tra queste il suo capo nereggiante. Noi salivamo si a frotte ruzzolando sui lapilli e sulle scorie, accompagnati da una turba di suonatori ambulanti e di poveri che ci aveva aspettati al varco nei tratti più ripidi della salita.
A mezza via ci fermammo per prendere fiato e fare un po’ si siesta. Allora un bello spirito mi obbligò a spifferare un sonetto a rime obbligate, che voglio qui riferire, come ricordo di quella gita, fatta in mezzo a quelle condizioni speciali di atmosfera:
Colore del giorno
Mentre ascendiam sul Cono del Vesuvio
Tra quelle rupi, un dì bollente lava,
Dall’alto ci minaccia Giove Pluvio;
(E qui un bel verso con la rima amava!).
Sembra tornato il giorno del diluvio;
Brontola il monte e dall’immane cava
Di fumo e di vapor lancia un profluvio;
(Qui perdonate un’altra rima: grava).
Incantevole scena! Dorme il mare
Sotto la nebbia; prendon la cuccagna
I congressisti; strimpella un giullare
Sul mandolino; e, color di lavagna,
Sfonda le nubi e maestoso appare
L’eccelso cono un prete in cappamagna!
Il sonetto, detto lì tra i fumi del "lacryma Christi" (8), non dispiacque, sebbene, come tutte le cose estemporanee sentisse non poco di quella ruvidezza che nasce dall’essere costretti a modellare i pensieri per comodo della rima, come un artista che fosse obbligato a disegnare una figura su cinque punti dati a capriccio. Se ne esce un mostro, la colpa non è poi tutta né del poeta né dell’artista.
Note
(1) Esattamente denominata Pompei Scavi. Da alcuni anni la stazione è stata abolita; essa era ubicata di fronte alla Porta Marina Inferiore, abituale ingresso per i visitatori degli Scavi di Pompei.
Da quel punto al Santuario intercorrevano circa due chilometri che bisognava percorrere a piedi e con difficoltà a causa delle condizioni di dissesto del fondo stradale. A Bartolo Longo premeva eliminare tale disagio per i pellegrini devoti che a raccolta chiamava con tanto fervore presso il Tempio della Vergine. A tale scopo inoltrò le pratiche presso la direzione delle Ferrovie dello Stato incontrando mille ostacoli burocratici e tecnici; invocò l’intervento di altissimi personaggi che perorarono la sua causa e finalmente ottenne quanto desiderava. "Il giorno 6 novembre 1886 superò ogni nostra aspettazione. Il primo treno straordinario e speciale diretto da Napoli a Valle di Pompei, che noi ottenemmo a nostre spese e che fu foriero di tanti e tanti treni, che incessantemente vennero poi, vengono e verranno carichi di pellegrini, di devoti e di benefattori, recò a questa nascente cittadina, che appena pochi anni addietro era una landa deserta, tutta una folla di visitatori ansiosi ed entusiasti, fra questi, personaggi ragguardevolissimi" (B.L.).
Bartolo Longo a sue spese provvide a costruire una stazione ferroviaria ("una baracca in legno") al punto di fermata del treno e tracciò da questa una strada che conduceva direttamente al Santuario. È l’attuale via Sacra. La stazione e la strada, si ricordi, furono costruite entrambe su terreni di proprietà della contessa Marianna De Fusco, consorte di B. Longo.
(2) Il territorio di Valle di Pompei, diviso e smembrato in zone diseguali, da secoli apparteneva ai quattro comuni vicini. Con la costituzione del Comune Autonomo e la ricomposizione del territorio, avvenuta il 29 marzo 1928, assunse l’attuale denominazione di Pompei.
(3) È la vecchia cupola del Tempio, rivestita di mattoni maiolicati policromi. A seguito dei lavori di ampliamento del Santuario, eseguiti dal 1934 al 1939, essa fu demolita e ricostruita più ampia e più alta come attualmente si ammira. Per motivi di armonia architettonica e per uniformità di stile con la restante nuova copertura della costruzione, i mattoni colorati, furono sostituiti con rivestimento di lastre di rame.
(4) Ludovico Pepe. (Ostuni 1853 – Monopoli 1901). Studioso e storico, dedicò la miglior parte della sua solida e valida cultura e della sua intelligente pazienza di ricercatore all’illustratore delle memorie della sua città natale. Si occupò anche di temi di interesse più generale, quale uno studio sulla rivoluzione in terra d’Otranto (1647-1648). Scrisse su Ignazio Ciaia, glorioso martire della rivoluzione napoletana del 1799: trattò con rara competenza argomenti di archeologia pompeiana pubblicati nel periodico Il Rosario e la Nuova Pompei ed in altre riviste. Nel 1887 videro alla luce le sue Memorie storiche dell’antica Valle di Pompei. Unico lavoro di questo genere e su questo argomento, ad esso ancora oggi bisogna fare riferimento come alla fonte esclusiva più autorevole e veritiera. L’argomento non era stato toccato che raramente ed in modo frammentario prima che il Pepe ne facesse oggetto di una ricerca condotta con rigore storico e suffragata da documenti originali.
A tale proposito si consideri che molti dei documenti di epoca angioina consultati e riportati nel suo lavoro andarono distrutti (incendiati dai tedeschi!) e pertanto l’opera del Pepe è ancora più preziosa a chi volesse riprendere o continuare questi studi.
In occasione della ricorrenza dei primi cinquant’anni del Comune di Pompei (1928-1987), divenuto raro ed introvabile il volume della storia del Pepe, ne è stata curata una ristampa fedele all’originale al fine di commemorare la ricorrenza e principalmente per stimolare gli studiosi a continuare le ricerche storiche sulla Valle antichissima. A Ludovico Pepe il Comune di Pompei ha intitolato una strada. Più meritatamente la Biblioteca Comunale porta il suo nome. In occasione dell’inaugurazione di essa, avvenuta nel 1978, fu scoperto nella Fonte Salutare un busto in bronzo dello storico, opera validissima dello scultore pompeiano Domenico Paduano.
(5) La tipografia fu fondata da Bartolo Longo e denominata del Ss. Rosario. Impiantata il giorno 7 luglio 1884, ai primi di settembre venne già alla luce la "Novena in onore di S. Domenico", il primo lavoro a stampa subito eseguito per importanza e per la mole di lavoro (circa centomila copie), dal fascicolo n° 9 (settembre 1884) il periodico "Il Rosario e la Nuova Pompei. Immensi l’entusiasmo e la gioia del fondatore: "La Celeste Regina del Rosario ha voluto impiantare presso la Sua Chiesa un altro elemento di civiltà per il Suo novello popolo pompeiano ed un novello produttore di industrie di arti, e questo è la Tipografia; … ed ecco come la fede, quando è operosa, diventa l’apportatrice di novella vita e di vero incivilimento per i popoli. Ed ecco come il cattolicesimo non è nemico del progresso, ma ne è la cagione e valido sostegno" (Bartolo Longo).
Nel 1892, fondato l’ospizio educativo per gli orfani della legge, la tipografia assunse l’attuale denominazione di Scuola tipografica Editrice per i figli dei carcerati e fu trasportata dalla prima sede, che era contigua al Santuario, nell’attuale grande edificio in via Sacra.
(6) Derivato dal francese. Generalmente titolo di rispetto e di riguardo che di solito veniva rivolto a persone di rango elevato o a gentiluomini. Nell’Italia Meridionale in passato (attualmente il termine è in disuso), Monsù era il cuoco per antonomasia, il capo.
(7) Grande valle semicircolare interposta tra il cono del Vesuvio ed il Monte Somma in tempi remoti era denominata la valle del Gigante. In seguito prese l’attuale denominazione di Atrio del Cavallo. Vi si lasciavano infatti in sosta i cavalli dei visitatori che si accingevano a scalare il cono del Vesuvio.
(8) Famoso vino prodotto già da tempi antichissimi con uve giunte a perfetto grado di maturazione. L’etnologo Gaetano Amalfi racconta: "Quando Cristo girava per il mondo capitò sul Vesuvio donde gli si fece ammirare Napoli. Allora egli commentò che il golfo era un pezzo di Paradiso abitato da birboni. Così pianse e le sue lacrime cadute al suolo fecero germogliare viti. Dall’uva di quelle viti fu prodotto il vino Lacrima Christi".
(Nicola Avellino – Il Rosario e la Nuova Pompei – n° 4 Marzo-Aprile 1987)
Il Longo è il vero fondatore di Valle di Pompei. È nato in questa mia provincia, in Latiano, e non ha raggiunto ancora il mezzo secolo (1); ma è un uomo di una attività prodigiosa e di una tempra di acciaio. Egli ha stampato nel suo cervello il motto del Quetelet, tanto vero in pratica: l’homme qui tends toujours vers le méme but, finit par acquérir une force morale immense (2).
Risultato fecondissimo di questa immensa forza morale, acquistata dal Longo con il suo carattere intraprendente, con il suo tenace buon volere ispirato e avvalorato dal sentimento religioso, sono appunto: la chiesa di Valle di Pompei, dedicata alla Regina delle Vittorie (3), l’asilo d’infanzia, l’ospizio di mendicità, le scuole per i bambini raccolti per le vie e guidati ad essere probi, onesti e laboriosi cittadini nell’età adulta (4).
A conseguire questa che io direi, mi si passi la frase un po’ secentistica, incarnazione delle tre virtù teologali a beneficio delle società, oggi concorrono spontaneamente credenti e miscredenti di ogni parte del mondo, perché la carità è una religione universale e fondamento di quella cristiana; è il mistico anello che lega i popoli di diverse religioni verso un ideale santissimo a cui tutti aspirano e che tendono di conseguire, o su questa terra o nella vita d’oltre tomba.
Lì presso è l’ufficio postale
Di contro a questi due uffici sorge il Santuario ed annesso a questo vi è un grandioso palazzo destinato ad asilo d’infanzia (11) e ad ospizio di beneficenza. Questo fu inaugurato nel Novembre scorso; quando io lo visitai era ancora in costruzione. Si direbbe venuto su d’un tratto, come Minerva dal cervello di Giove. Ed oggi raccoglie più di cento bambini che prima erravano vagabondi, destinati adulti a popolare le prigioni.
D’innanzi a quella colonia d’infelici che mi sfilarono nel corridoio del piano inferiore, io mi sentii allargare il cuore. Si creda o non si creda, d’innanzi a quello spettacolo ci si sente migliori e degni della nostra differenza specifica nella serie zoologica! È questa una religione operosa, la quale non si mantiene nella sola sfera delle relazioni tra il sensibile e il soprasensibile, tra la creatura e il suo Fattore, ma diviene madre amorosa che alimenta i suoi figli e ne guida i passi vacillanti. Quando parla poi la carità, la fede regna sovrana nel cuore dell’uomo; il negarlo è un voler illudere se medesimi!
Note
(1) Bartolo Longo nacque il giorno 11 febbraio 1841 a Latiano, in provincia di Lecce (oggi provincia Di Brindisi) da Bartolomeo e da Antonia Luparelli. Morì a Pompei il 5 ottobre 1926. È stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 26 ottobre 1980. Le sue spoglie sono esposte alla venerazione dei fedeli nella Cripta del Santuario. Al fine di appagare un ardente desiderio del Beato, la teca di cristallo che racchiude il simulacro è stata sistemata sotto il Trono della Vergine.
(2) L’uomo che tende costantemente allo stesso bersaglio, finisce per acquisire una forza morale immensa.
(3) Esattamente il Tempio è dedicato alla Vergine del SS. Rosario: "Virgini SS. Rosarii Dicatum" si legge, scritto a grandi lettere di bronzo, sulla facciata del Santuario. Regina delle Vittorie invece, è un appellativo caro a Bartolo Longo, uno dei tanti con cui sovente il Beato invocava la Vergine.
(4) "Se vogliamo salvare la società, cominciamo per tempo ad educare cristianamente la generazione che sale: I fanciulli. Nessuno si creda esentato da quest’opera di rinnovamento morale della società per mezzo dell’istruzione religiosa e della pratica dei sacramenti". In tali termini si era espresso Leone XIII; nell’insegnamento del Papa, Bartolo Longo trova la conferma di quanto già da tempo aveva intuito, più di tutto, lo stimolo ed il fervore ad iniziare in Pompei un’opera educativa ad affiancare a quella religiosa. Nel 1881 il primo passo. A fianco del Santuario ancora in costruzione, Bartolo Longo fece costruire "quattro mura rustiche", un modesto locale nel quale cominciò ad accogliere la domenica pomeriggio una ventina di fanciulli figli di contadini della Valle, ai quali impartiva i primi rudimenti del Catechismo. L’anno seguente, 1882, con il 1° gennaio l’inaugurazione dell’opera Catechistica Pompeiana. L’istruzione è riordinata su altre basi: vengono formati due circoli separati per i fanciulli e le fanciulle, si aggiungono anche gli adulti ai quali Bartolo Longo aveva anche assicurato che a chiunque fosse venuto la sera a trovarlo avrebbe fatto insegnare il leggere e lo scrivere. Mirabile lo sviluppo della scuola: dopo il primo anno era frequentata da un centinaio di fanciulle ed altrettanti fanciulli, una quarantina di uomini, una ventina di donne.
(5) "Oltre della scuola serotine in Valle di Pompei, a cui accorrono fanciulli e giovanetti per apprendere i primi rudimenti delle lettere e della morale, abbiamo a nostre spese iniziato una scuola particolare per tutti quei fanciulli che già lavorano nel nostro opifizio, al fine di farli diventare un giorno artisti perfetti ed istruiti, vuoi tipografi, vuoi legatori, vuoi macchinisti. E per incoraggiarli a studiare e coltivare lo studio della lingua italiana, tanto per capire quel che stampano, li provvediamo a nostre spese di libri, di carta, di penne e di ogni altro occorrente, facendoli ammaestrare da un idoneo maestro patentato" (B.L.).
(6) Si riferisce al Periodico "Il Rosario e la Nuova Pompei" che vide la luce con il primo, il 7 marzo 1884 stampato però a Napoli dalla Tipografia di A. e S. Festa. "Se Dio vorrà, nella nostra casa apriremo una sala di lavoro per i fanciulli pompeiani e cominceremo con l’impiantarvi una tipografia la quale avrà nome dal Rosario" (B.L.). La Tipografia in breve volgere di tempo fu impiantata; nell’agosto 1884 e già pronto per la stampa il primo lavoro: la Novena ad onore di S. Domenico. Il numero nove del periodico, settembre 1884, è impresso in Valle di Pompei dalla tipografia del SS. Rosario.
(7) "Ed una sala di lavoro di già è aperta per le fanciulle che imparano a piegare, cucire e legare il giornale ed I libri che vengono qui stampati. Confessiamo l’immensa soddisfazione nel vedere queste fanciulle ripulite ed educate, attendere con gran diligenza al lavoro; apprendono l’arte e di già ogni settimana cominciano a portare alle loro famiglie il lucro delle loro incipienti fatiche" (B.L.).
(8) L’Ufficio Postale fu istituito nel maggio del 1884 come Collettoria di Valle di Pompei. Con il 1° dicembre 1885 fu già elevato ad Ufficio Postale di II Classe.
(9) Il giorno 16 del corrente luglio (1886) dovrà essere qui a Valle definitivamente impiantato il nostro ufficio telegrafico. Stampa, Telegrafo e Vapore sono le tre cose di cui non sa far a meno la civiltà moderna, e queste tre cose abbiamo già ora a Valle di Pompei. La nostra tipografia è già ormai contata tra le migliori; in qualsivoglia giorno dell’anno il treno tra andata e ritorno, ferma due volte a Valle di Pompei; e il filo telegrafico ci porterà sulle ali del vento dai nostri associati i comandi a noi e le suppliche a Maria.
(10) Per farsi un’idea di quale rilevanza fosse l’incremento annuo del movimento postale e la mole di materiale spedito, basti osservare che nell’anno 1894 Bartolo Longo inviò in tutto il mondo, dall’ufficio postale di Valle di Pompei, 801225 copie del periodico, 60.018 lettere, 25.889 pacchi e plichi, 1.253 telegrammi. Per il tutto spese lire 29.832 ed 87 centesimi.
*Una gustosa pagina di storia scritta da un attento e scrupoloso osservatore dell’ottocento in visita a Pompei (Parte Quarta)
Dall’ospizio passai al Santuario che fu la meta della mia escursione. Come in Pompei i tempi pagani, così qui la chiesa dedicata alla Vergine non è soltanto la casa di preghiera, ma un santuario dell’arte (1), ed aggiungerei anzi un monumento sincrono dell’arte napoletana.
Quando io la visitai nel settembre scorso era tutt’ora in costruzione. L’intempiatura generale era terminata, come pure le decorazioni dell’absida, della Cupola e della nave trasversale. L’architettura è del chiarissimo Prof. Antonio Cav. Cua (2) ed è opera magnifica. È una chiesa a croce latina, ricca di doratura e di freschi e forse fin troppo ricca (3). Ma prima di giudicarla bisogna metterla in relazione con i luoghi in mezzo ai quali sorge, luoghi pieni di tinte gaie, calde, pittoresche. Bisogna guardarla sotto il cielo di Napoli, in mezzo a quella popolazione ricca di fantasia e semi-orientale. Allora quello sfarzo che colpisce l’occhio intona con il resto del paesaggio ed armonizza con questo.
Sotto la volta dell’absida il Cav. Vincenzo Paliotti (4) ha dipinto un gruppo di angeli bellissimi che via via, sollevandosi verso il cielo e intrecciandosi con quelli dei piani sovrapposti, fa corona all’Altissimo che è in atto di benedire.
Il sommo pittore di tanti velarii e siparii di teatro ha voluto mostrare che il suo pennello risponde egregiamente anche alle sublimi ispirazioni dell’arte religiosa. E questo ci fa dimenticare l’effetto un po’ teatrale di alcune scene, di alcune figure.
Si costruiva in quel tempo il tabernacolo dell’altere maggiore con marmi dei Pirenei e di Carrara (5). I cinque angioli di bronzo, che dovevano essere collocati ai piedi del trono della vergine, erano allora fuor di posto; e così potei ammirare da vicino quell’opera che fa molto onore al Cav. Salvatore Cepparulo (6), napoletano, il quale ispirandosi nelle opere stupende di Donatello e di Mino da Fiesole ha saputo soffiare l’alito della vita nella informe materia.
Mi mostrarono pure due statue scolpite in marmo bianco dal Commendatore Federigo Maldarelli (7) di Napoli e rappresentanti una "l’orazione mentale del Rosario, l’altra "L’orazione vocale (8). È questa la prima volta che il valente artista ha sostituito lo scalpello al pennello. Però, tutti gli intelligenti di arte preferiranno di ammirare il Maldarelli pittore nello stupendo lavoro dell’estasi di Santa Caterina da Siena (9) che decora uno degli altari di questo tempio e che attrae a sé tutti gli occhi dei visitatori. Questa sola tela basterebbe a richiamare in questo Santuario tutti gli amatori dell’arte ed a mostrare che anche oggi da poche menti elette, e sarei per dire privilegiate, si sente la vera arte religiosa scevra dalle fisime del verismo.
Accanto alla chiesa oggi vi è l’Oratorio dove accorrono i credenti in numero grandissimo, siccome potei notare io stesso nei due giorni che mi trattenni in Valle di Pompei.
Ed ora basta. Ho voluto segnare degli appunti, non descrivere il Santuario della nuova Pompei. L’opera non è ancora compiuta e vi si lavora alacremente per condurla a termine. Mi dissero che vi è una colonia di 250 tra artisti ed operai, occupata a quest’opera meravigliosa, nata dalla fede, alimentata dalla carità e rafforzata dalla speranza di un avvenire migliore.
Il tempio di Valle di Pompei diverrà fra qualche anno il nucleo di un paese; ma già fin d’ora è il più cospicuo centro di attività religiosa artistica e intellettuale di tutta la zona che circonda il monte, "sterminator Vesevo". Ed io, stringendo la mano all’Avv. Longo, gli dirò nell’orecchio due sole parole: Avanti, Excelsior!
Lecce nel Natale del 1886. Autore: Cosimo De Giorgi
Note
(1) "E demmo ordine al nostro architetto Giovanni Rispoli che non guardasse a spese, ma si studiasse di rendere la Chiesa del Rosario di Pompei un monumento di arte religiosa moderna da contrapporre ai monumenti dell’arte pagana antica". (B.L.).
(2) Bartolo Longo ci narra nella sua Storia del Santuario come il professore dell’Università di Napoli Ing. Antonio Cua (1818-1889) si offrì a dirigere gratuitamente i lavori del Tempio. Riportiamo il racconto operando qualche taglio (doloroso) impostoci dalla tirannia dello spazio. Siamo nell’anno 1886. "Mi recai a casa di un intimo e cordiale mio amico, il Cav. Tarquinio Fuortes (1848-1927), professore di matematica. Quel mattino lo trovai circondato dai suoi di famiglia che facevano accoglienze ad alcune signore ed a un signore grave di aspetto e di età. Senza preamboli entrai a discorrere dei fatti occorsi a Pompei. Quello sconosciuto, poi che mi ebbe udito alquanto, interruppe: "Chi è l’architetto che dirige i vostri lavori? – Non abbiamo architetti – risposi - . – Avete almeno un disegno? Ed io pronto, misi la mano in seno e ne trassi quel foglio istoriato che i lettori sanno. Quel signore non seppe ritenere un sorriso di compassione e soggiunse: - Ma perché in un’opera d’arte non valersi dell’uomo dell’arte? – Il compenso di un architetto assorbirebbe metà della somma che raccogliamo con stenti e disagi. – Vi potrebbero essere anche degli architetti che si offrissero gratuitamente. Date a me quel disegno ed io ve lo farò secondo l’arte.
Mi volesse costui fare un tiro, pensai malignamente fra me medesimo, dicendo offrirsi gratuito e poi richiedermi la ricompensa? E guardai negli occhi il mio amico Tarquinio. Costui mi lesse nell’animo ed esclamò: - Bartolo, questo signore è il cavalier Antonio Cua, illustre professore della Regia Università di Napoli, ed è uno degli uomini più buoni di questo mondo. Egli si offre gratuitamente. Balbettai alcune parole di ringraziamento; quindi, quel nobile cuore concluse: - Poiché fate una chiesa a poveri contadini ed a furia di soldi elemosinati, io non solo vi darò il disegno gratis ma ancora verrò ad assistere senza ricompense di sorta alla costruzione e ci rimetterò le spese dei viaggi ogni volta che occorrerà recarmi a Pompei".
Il professore Cua tenne fede alle promesse, donò il disegno e, per sette anni, dal 1876, diresse di persona e gratuitamente i lavori per la costruzione del Tempio.
(3) "La decorazione: il concetto informatore è di attuare il massimo decoro per la per la casa della Nostra Signora; tutto deve ispirare devozione; ed ogni parte collegata al tutto deve formare la magnificenza del Tempio Cristiano dedicato alla regina dei Cieli.
Il compito è arduo… nulla sarà risparmiato a che la Chiesa raggiunga il suo perfetto e completo risultato. Animati da santo entusiasmo sapremo cavar profitto da ogni cosa…" (arch. G. Rispoli). "… ora una lode a chi aspetta. L’architetto Giovanni Rispoli di Napoli, autore della decorazione e direttore dei lavori, ha speso ogni cura e quanto era in poter suo affinché l’opera riuscisse" (B.L.). All’architetto Rispoli infatti Bartolo Longo aveva affidato la direzione di tutti i lavori che si eseguirono nel Tempio e gli aveva richiesto anche consigli e disegni per la costruzione e l’allestimento di tutta la parte monumentale. Sono suoi infatti la decorazione interna del Santuario, il disegno e l’esecuzione della facciata, il ciborio, l’altare maggiore, la cantoria, il disegno dello stupendo cancello che chiude la balaustra.
(4) Vincenzo Paliotti, romano di nascita, in giovane età si trasferì in Campania dove svolse in prevalenza la sua attività artistica. Si ammirano i suoi affreschi nella Cattedrale di Castellammare di Stabia ed anche in quella di Benevento, nella Chiesa del Gesù Vecchio di Napoli e nella Cattedrale di Capua; il secondo sipario del Teatro San Carlo di Napoli è opera sua; suoi infine alcuni dipinti al palazzo Farnese in Roma. "Vincenzo Paliotti è stato uno di quegli artisti che sin dal principio mi è stato costante compagno nei lavori di questo Santuario ed acuto interprete e fedele esecutore dei miei concetti artistici e dei temi più facili che io soglio porgere ai miei compagni di arte per la più nobile manifestazione delle bellezze cristiane e delle idee puramente ascetiche" (B.L.).
Di tutti i dipinti del Paliotti nel Santuario resta solo una parte; purtroppo durante i lavori di ampliamento del Tempio (1934-1939), alcuni affreschi ed i dipinti della Cupola dovettero essere sacrificati.
La Cupola infatti fu interamente ricostruita più ampia e più alta; l’abside fu arretrata, furono aggiunte le due navate laterali al fine di ricavare maggiore spazio per accogliere i numerosi fedeli.
Attualmente della vasta opera del Paliotti restano: - i quindici medaglioni dipinti su rame che coronano il quadro della Madonna. Rappresentano i quindici misteri del Rosario; - Il soffitto della navata centrale, vasto affresco firmato e datato 1888, vi è rappresentato l’ultimo mistero glorioso con al sommo la trinità che incorona la vergine, il tutto circondato da angeli in atto di omaggio. Nelle ogive sono affrescati San Domenico, San Benedetto, San Francesco d’Assisi e Sant’Agostino. Negli interspazi infine, tra i finestroni, San Pio V e San Paolino; - L’affresco del succielo della cantoria, con Santa Cecilia protettrice della musica e gruppi di angeli assorti nel canto.
(5) Bartolo Longo, fiducioso sempre negli aiuti della Provvidenza, non badava a spese. Il Trono della Vergine e l’Altare Maggiore dovevano essere un autentico gioiello, prezioso e degno, una opera finissima d’arte. Ordinò infatti i marmi più fini e più belli a Carrara ed alla grande Marmerie di Bagneres de Bigorre, negli Alti Pirenei. "Quel luogo (Lourdes) in cui ventisei anni or sono appariva la regina del Cielo con il Rosario in mano, oggi doveva somministrare i marmi più splendidi per erigere un Trono alla Vergine del Rosario nella Valle di Pompei" (B.L.).
(6) Il de Giorgi si riferisce ai cinque angeli pronto per essere collocati sul piano del Trono. Le sculture sono alte poco più di due metri, modellate dall’artista napoletano Salvatore Cepparulo e fuse dalla ditta Alfano; costarono lire settemilacinquecento. "Il bravo professore S. Cepparulo autore delle cinque monumentali figure, in quello slancio di vena artistica, che forma l’originalità e la nota nuova delle sue stupende produzioni d’arte, in un momento di assai felice vena, si era ispirato ad un ideale ascetico che completamente l’aveva signoreggiato e trascinato a delle figure di uno slancio tale da far restare compresi di ammirazione quanti le hanno vedute" (B.L.).
I cinque angeli furono sistemati sul piano del Trono secondo il progetto del bravo Rispoli. A seguito dei lavori di arretramento dell’Altare si diede nuova e più snella sistemazione a tutto il complesso monumentale. Dei cinque angeli infatti, solo due furono lasciati al loro primitivo posto (come oggi si vedono); altri due sono stati collocati nel parco del Piazzale Giovanni XXIII, il quinto, infine, nei giardini, a destra di chi guarda la facciata del Santuario. Dello stesso artista, si ammirano: sul dorsale dell’Altare Maggiore, sei testine di Cherubini di bronzo a tutto tondo incastonati in altrettanti dadi di marmo nero; il cancello della balaustra, finissimo lavoro di bronzo e d’argento; le statuine dei Padri della chiesa e dei Santi, tra cui S. Pietro e S. Paolo, che circondano il ciborio dell’Altare Maggiore.
(7) Federico Maldarelli (Napoli 1826 – ivi 1893). "Insigne pittore napoletano, nel maggio 1879, per sua specchiata pietà, vedendo cresciuta ogni giorno la devozione di tanti signori napoletani e forestieri verso la Vergine del Rosario di Pompei, la cui immagine per la umidità della Parrocchia era quasi nel totale suo deterioramento, si offerse gratuitamente a fare una più perfetta e completa riparazione" (B. L.). È il secondo restauro del quadro della Madonna; il primo era stato rozzamente eseguito nel 1876 da Guglielmo Galella, "pittore artigiano". Nel 1965 il quadro fu nuovamente restaurato, finalmente seguendo i moderni canoni dell’arte, presso l’Istituto del Restauro dei Monaci Benedettini Olivetani in Roma.
(8) Le due statue sormontavano i portali di marmo che si aprivano ai due lati del Trono. A seguito dell’ampliamento del santuario, i due portali furono aboliti e le due statue ebbero diverse collocazioni. Attualmente esse si possono ammirare nella Cripta del Santuario, ai lati dell’altare.
(9) Pregevole lavoro del Maldarelli, firmato e datato 1883. Raffigura Santa Caterina che riceve le Sacre Stimmate dal Crocifisso apparsole in estasi. Attualmente il quadro è collocato nel penultimo altare alla destra per chi entra nel Santuario.
Da notare, sotto la mensa dello stesso altare, una copia in marmo della Santa Cecilia del Maderno.
(Nicola Avellino – Il Rosario e la Nuova Pompei – n° 5 Settembre-Ottobre 1987)
*Cammino Giubilare Longhiano 01.10.2022/01.10.2023